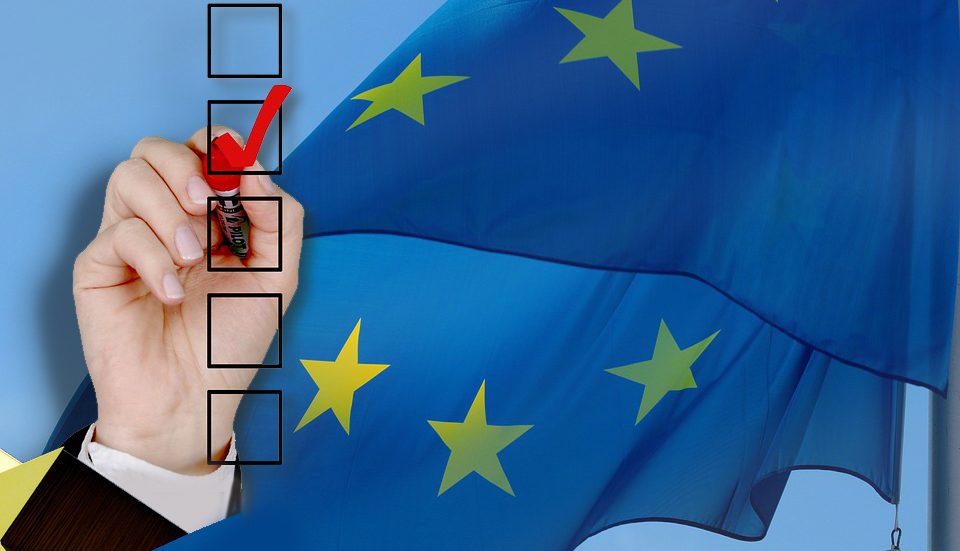«Il Paese ha bisogno di persone credibili per storia e valori vissuti, impegnate a cercare ciò che unisce, e a disegnare i tratti di un futuro migliore, che include tutti e che può essere compreso e costruito con la partecipazione di tutti». Ne è convinto Sebastiano Nerozzi, professore di Storia del Pensiero economico all’Università Cattolica del Sacro Cuore e segretario del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici in Italia, che riflette di democrazia e partecipazione – temi al centro dell’appuntamento che si terrà a Trieste a inizio luglio – nell’imminenza della tornata elettorale con la quale gli italiani rinnoveranno i propri rappresentanti al Parlamento europeo oltreché i vertici delle Amministrazioni regionali in Piemonte e municipali in circa 3.700 Comuni.
Professore, a poco meno di un mese dalla Settimana sociale, l’8 e 9 giugno tutti gli italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni europee. Un appuntamento di democrazia e partecipazione. Perché è importante non trascurare il voto?
L’Europa vive oggi una stagione particolarmente difficile e ha bisogno della partecipazione di tutti. Per ottant’anni il processo di integrazione europea ha consentito di mantenere la pace in un continente che per secoli non aveva mai smesso di combattere. Due guerre mondiali sono state originate dallo scontro fra le potenze europee per il controllo delle risorse strategiche e dei mercati. Nazionalismi e totalitarismi avevano prosperato nella divisione fra Stati, strumentalizzando la difesa dell’interesse e della sovranità nazionali per costruire regimi illiberali, giustificare aggressioni e violare sistematicamente i diritti dei popoli e di milioni di persone. Il processo di integrazione europeo, iniziato nel 1951 proprio dalla condivisione di risorse fondamentali come il carbone e l’acciaio, ha posto fine a questa immane serie di tragedie. Esso è stato voluto da tre leader lungimiranti e di grande statura politica, come Konrad Adenauer, Robert Schuman, Alcide De Gasperi, cattolici che avevano sperimentato la dura esperienza della guerra, del totalitarismo e della persecuzione. Con grande realismo, essi hanno pensato il processo di unificazione europea come un cammino progressivo, per tappe, ma con un obiettivo chiaro: quello di rendere impossibile il ripetersi di una guerra in Europa e, allo stesso tempo, tutelare la libera autodeterminazione dei popoli e il rafforzamento della democrazia. Il processo di integrazione ha creato relazioni cooperative tra i Paesi europei, impegnandoli a cedere parte della propria sovranità, a condividere regole, leggi e risorse strategiche. Ciò ha significato, come cittadini europei, poter mettere in comune aspetti sempre più rilevanti della nostra vita quotidiana: dal lavoro, ai risparmi, alla moneta, alla formazione universitaria, alla difesa dell’ambiente e dei diritti individuali, alle spese per il sostegno all’agricoltura e alla coesione sociale e territoriale, fino ai piani di Next Generation EU che hanno consentito, durante e dopo la Pandemia, di far crescere, per la prima volta dopo tanti anni, l’occupazione nel nostro Paese. La costruzione europea che ha portato così tanti benefici ai nostri Paesi e alle nostre esistenze merita oggi di essere riconosciuta e tutelata con un’ampia partecipazione al voto. Votare è il modo più semplice e più efficace per dire: «L’Europa è nostra e ci sta a cuore. È la nostra casa comune e vogliamo dire la nostra, affinché essa sia ben governata e continui a vivere nella pace e nella prosperità anche in futuro».
Eppure l’Europa è spesso contestata e fatta oggetto di molte critiche. Perché?
Certo molti aspetti possono essere migliorati. Negli anni del neoliberismo imperante, l’Europa è stata eccessivamente concentrata sull’integrazione dei mercati e sulle regole di disciplina finanziaria, senza coltivare adeguatamente la coesione sociale e l’integrazione politica. Inoltre il funzionamento dell’Unione europea presenta una grande complessità che nasce dall’esigenza di mettere insieme bisogni e sensibilità diverse, su materie differenziate, per un ampio numero di Paesi membri. I meccanismi decisionali sicuramente hanno bisogno di essere rivisti, soprattutto tenendo conto che l’Europa è composta oggi da 27 Paesi membri e domani potrebbe arrivare a 35. Uno snellimento delle procedure, con la limitazione dei poteri di veto, e un rafforzamento delle istituzioni comunitarie sono necessari a far sì che l’Europa possa parlare con una voce sola ed essere espressione democratica della volontà dei suoi cittadini. Oggi il destino dell’Europa è messo a repentaglio non solo dagli attacchi da parte di autocrazie bellicose che desiderano imporre il proprio potere con la forza delle armi, ma anche da un certo scetticismo se non da una vera e propria ostilità che serpeggia verso le istituzioni europee, fomentata da movimenti populisti e gruppi di potere che vorrebbero tornare indietro sulla strada dell’integrazione in nome della difesa di interessi e identità nazionali spesso dipinte in termini assai semplificati se non palesemente deformati. Ma si tratta, a ben vedere, di una strada senza sbocco. Nella nuova globalizzazione che si sta affermando dopo le crisi del 2007-2008, con una crescente contrapposizione tra Cina, India e Stati Uniti, con un potere sempre più pervasivo di colossi economici privati, con nuove tecnologie che richiedono investimenti enormi, i singoli stati europei non hanno una forza adeguata a difendere i propri interessi e portare avanti la propria visione del mondo. Solo uniti i circa 400 milioni di europei, che insieme rappresentano il primo mercato mondiale, possono far valere il proprio punto di vista e darsi strumenti concreti ed efficaci per promuovere la democrazia, la pace, lo sviluppo, la cura del creato.
In una democrazia, recarsi alle urne non è la sola forma di partecipazione. Quali opinioni, necessità e proposte sono emersi in questi mesi verso Trieste sui quali Istituzioni, società civile e comunità ecclesiale possono riflettere e confrontarsi per una cittadinanza sempre più attiva e coinvolta?
La cura del bene comune è prima di tutto, partecipazione sociale. Nei quartieri delle nostre città e nei nostri borghi, crescono nuove forme di solidarietà e di partecipazione per la cura del bene comune: tante sono le associazioni e i gruppi attivi nell’educazione, nell’accoglienza dei migranti, nella cura dell’ambiente, nell’accompagnamento e nell’ascolto delle persone più fragili. Queste forme di partecipazione rendono “solide” le nostre comunità, ed esprimono bene la concretezza dei principi di sussidiarietà orizzontale e verticale. Oggi è importante che anche le Amministrazioni ascoltino e favoriscano queste forme di cittadinanza attiva, più o meno organizzate, e le valorizzino come esperienze originarie di democrazia e veri attori di innovazione sociale. Nel cammino verso la Settimana sociale, ci siamo fatti ammaestrare da esperienze come quella di Labsus, il Laboratorio della sussidiarietà fondato dal professor Gregorio Arena del Politecnico di Torino, che da oltre 10 anni promuove i “Patti di collaborazione”, fra associazioni, cittadini e pubbliche amministrazioni, per la gestione condivisa di beni comuni: un parco, una piazza, un servizio per i cittadini, un immobile sequestrato alle mafie. Migliaia di esperienze in tutta Italia raccontano la capacità dei cittadini di mobilitarsi per curare il bene comune. Anche la Commissione europea, nel dicembre 2023, ha emanato una “Raccomandazione sulla promozione del coinvolgimento e della partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile, ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche”. Certo questa partecipazione deve poi dar luogo anche a forme di impegno politico diretto a livello locale, nazionale e anche europeo. Oggi come non mai la politica ha bisogno di persone ben preparate e motivate, che, partendo da esperienze autentiche di servizio alla persona e di impegno sociale, accettino di misurarsi con la sfida di una “carità politica” che abbraccia tutta la comunità.
Cosa è emerso nel cammino di preparazione a Trieste che può essere “consegnato” a chi verrà eletto per contribuire a realizzare il bene comune?
Oggi le persone vivono un grande senso di isolamento, di solitudine e di incertezza. Molti si scoraggiano di fronte alle difficoltà della vita. Forte è la tentazione di soffiare sul fuoco delle paure e degli interessi particolari per raccogliere un facile consenso. Ma questo alimenta un clima sempre più tenebroso, desolante e violento che fiacca la capacità delle persone di attivarsi e di mettere a frutto le proprie energie. Facile è anche gettare discredito sull’Europa, che è lontana e non può rispondere, spostando altrove la responsabilità di mali che spesso nascono proprio dalla nostra incuria per il bene comune e dalla nostra incapacità di affrontare alla radice i problemi del nostro Paese. La politica deve smettere di alimentare il gioco perverso della paura e della sfiducia, e trovare un linguaggio nuovo, fondato sulla speranza e sulla fiducia. Il Paese ha bisogno di persone credibili per storia e valori vissuti, impegnate a cercare ciò che unisce, e a disegnare i tratti di un futuro migliore, che include tutti e che può essere compreso e costruito con la partecipazione di tutti. Ci auguriamo che i nuovi eletti facciano propria questa spinta ad avvicinare i cittadini alle istituzioni e a creare una democrazia inclusiva e coinvolgente, che suscita nuove energie e apre alla partecipazione.