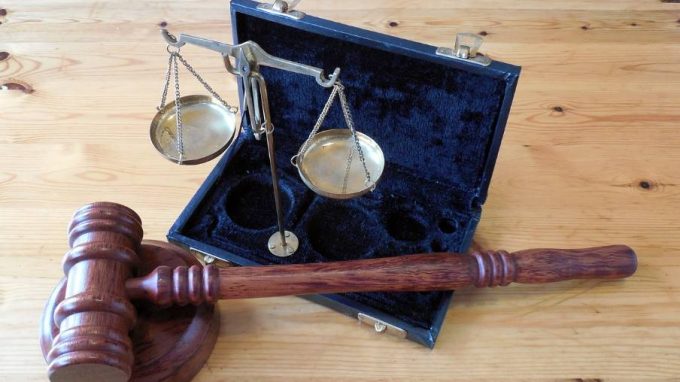«Non ho mai capito se il carcere abbia un senso e se la forma di pena nella detenzione sia una cosa giusta. Le condizioni attuali del carcere, certamente, rendono ancora più problematico tutto questo». A dirlo, con i cronisti, è l’Arcivescovo che poco dopo partecipa al convegno «Ricostruire la speranza: pena e comunità in dialogo» presso l’Università Cattolica.
«L’impianto di chi si occupa di giustizia, penso debba essere quello di una riforma profonda, anche se non saprei indicare una via da percorrere, se non quella della ricerca del bene comune, che significa anche il bene di chi lavora in carcere, di chi è detenuto e il bene possibile da chiedere a coloro che hanno fatto dei danni alla società, secondo la logica della giustizia riparativa che sta diventando un’ipotesi realistica. L’opera di visitare i carcerati è una testimonianza che queste persone in qualche modo fanno parte della comunità e non sono estranei», ha aggiunto.
Un tema complesso, insomma, quello del rapporto tra pena, comunità e speranza, che vede per l’intera mattinata confrontarsi diversi relatori, presente un folto pubblico, tra cui molti studenti e docenti, il Moderator Curiae monsignor Carlo Azzimonti e il vicario episcopale di settore monsignor Luca Bressan. Assise promossa dall’Ateneo in collaborazione con la Diocesi, e aperta dalla rettrice Elena Beccalli.

Cattolica, un percorso sulla speranza
«Declinare il tema giubilare, come faranno tutte le nostre 12 Facoltà fino a giugno, promuovendo convegni e dibattiti per capire come la speranza può essere alimentata in un contesto transdisciplinare, sta molto a cuore alla nostra Università», spiega Beccalli, delineando il senso complessivo del palinsesto di iniziative che si avviano proprio con l’incontro dedicato alla pena. «Iniziamo affrontando un tema forte, che chiama in causa la responsabilità di ciascuno. In tutti gli ambiti, ma specialmente in quello giudiziario, quando bisogna costruire la speranza ci si affida ai buoni propositi e agli auspici. Ma quando bisogna ricostruire la speranza di coloro che hanno sbagliato, oltre ai propositi e agli auspici, si deve fare affidamento su un “di più” che è rappresentato dalla consapevolezza che la giustizia può essere strumento di misericordia e di rinnovamento. Vorrei sottolineare la convinzione che, per ricostruire la speranza, è necessario fare affidamento sull’altro: entra in gioco, così, la comunità chiaramente evocata nel titolo dell’incontro. Il dialogo tra “pena” e “comunità” è indubbiamente complesso, ma indica la strada obbligata».

Specie a fronte della situazione spesso drammatica delle carceri con il loro sovraffollamento, come evidenziano il preside della Facoltà di Giurisprudenza Stefano Solimano e Gianluca Varraso, docente e referente di Ateneo per la Convenzione per la promozione dello sviluppo culturale e la formazione universitaria dei detenuti, promossa dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. «Occorre – dice quest’ultimo – ricostruire la speranza con un recupero della dignità delle persone detenute e di diritti che spesso diamo per scontati, ma che non lo sono. Questo è il punto-chiave dell’ordinamento penitenziale, in un momento in cui il numero dei suicidi in carcere è il più alto di sempre: 83 nel 2024, a cui vanno aggiunti vari casi dubbi».
L’Arcivescovo: «Visitare i carcerati»
Poi l’intervento dell’Arcivescovo, che parte da San Paolo e dal Libro dell’Apocalisse affrontando il tema della pena e del potere, per giungere al cuore della questione attraverso la citazione del Vangelo di Matteo al capitolo 25, «Ero in carcere e siete venuti a visitarmi» -, «definito nel suo complesso da alcuni un Vangelo laico, perché offre vie verso il paradiso per tutti, anche se non si ha la fede, in quanto implica una pratica di amore».
«Questa opera di misericordia corporale è la testimonianza che i carcerati fanno parte della comunità dei discepoli e non sono vite finite in un mondo a parte. La società si protegge da coloro che l’hanno danneggiata e, certamente, le mura dei penitenziari sono ciò che sembra dissuadere dal cercare rapporti tra “dentro” e “fuori”, mentre la visita è un’immagine del carcere come appartenente alla città».
«Considerare i detenuti persone – prosegue – attesta che la comunità si prende cura della loro vicenda, ha a cuore il loro bene, e qui si manifesta un ruolo fondamentale della comunità sociale per propiziare anche il reinserimento del carcerato. Non si tratta di un’elemosina di tempo e attenzione del ricco che lascia qualcosa al povero, di chi sta bene a chi sta male, ma del desiderare il bene della persona che suscita una possibilità di risposta e di relazione: in questo senso la carità, che non è unidirezionale e fa crescere, è una provocazione alla libertà individuale di ognuno e comporta un’ineliminabile via di personalizzazione del percorso relazionale».
Riconoscere la dignità della persona in carcere
Il riferimento è ad alcuni termini come «rieducazione», «che è compreso nella Costituzione, ma è ambiguo, e suona persino sinistro in contesti di dittatura»; reinserimento («ma dove? Perché, talvolta, si deve costatare che l’ambiente da cui viene un detenuto contribuisce alla corruzione della persona, per cui tornare al luogo di origine può esporre di più alla recidiva»); riabilitazione, «anch’essa parola ambigua, perché implica lo stigma impresso dal delitto commesso o dalla condanna subìta»; risarcimento, «parola interessante, che apre ai cammini della giustizia ripartiva».
Da qui la conclusione: «Chi visita il carcerato contribuisce a riconoscere la dignità di una persona favorendo la speranza».
Le condizioni che ostacolano la speranza
A soffermarsi «sulle condizioni ostative della speranza nell’ambito della giustizia penale, che si sostanziano nell’oggettualizzazione del detenuto», è Gabrio Forti, accademico dei Licei e ordinario emerito di Diritto penale. «La burocratizzazione del decidere, l’eccedenza rivendicativa, l’abbondanza sanzionatoria, la ricerca del capro espiatorio a tutti i costi – come si vede nelle immagini, per esempio, dei rimpatriati in catene dagli Stati Uniti -, la mancanza di empatia, l’egemonia nei codici elaborati da macchine che sembrano poter fare a meno degli umani», sono tutti segnali inquietanti, suggerisce Forti, «mentre la risocializzazione implica la narrazione dei percorsi delle persone che, quando sono chiusi dallo straripare del digitale», sono impossibili.

Che fare quindi? «Non esistono soluzioni facili, ma la prima strada è decostruire le logiche sacrificali della giustizia penale, richiamando la centralità della presunzione di innocenza scritta nel nostro ordinamento penale. E pensare, come si fa da anni in Cattolica, a vie di giustizia riparative e trasformative, che si rivelano ricostruttive di rapporti. La giustizia in senso pieno non poggia sull’idea di ordine, ma sul compito infinito della rigenerazione».
Parole a cui fa eco Giovanna di Rosa, presidente della Corte d’Appello di Brescia, sottolineando la necessità «di un recupero in chiave dialogica della funzione rieducativa della pena, dove la comunità diventa parte attiva di tale dialogo. Attraverso la giustizia riparativa si possono immaginare percorsi in cui l’intero sistema ritrova la sua ricomposizione e pace».

Concordi altri relatori, tra cui don Marco Recalcati, cappellano di “San Vittore”: «È facile dipingere il volto del mostro e non sempre la comunità è disposta ad accogliere chi, durante il suo cammino, ha commesso scelte sbagliate. Ma quello che mi colpisce sempre è che, quando si rompono gli stereotipi e la diffidenza viene superata, queste persone sono risorse su cui poter contare, un lievito per la comunità».

«Non girarsi dall’altra parte»
Infine, le conclusioni affidate a don Nazario Costante, direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro: «Questo confronto ci ha aiutati a crescere nella trasversalità dello sguardo per un vero umanesimo integrale. Non possiamo limitarci a uno sguardo parziale sulla realtà, perché ogni persona va riconosciuta e accolta nella sua totalità, nella sua unità e nella sua unicità. Spesso la difficoltà su questi temi sta nel fermarsi alla superficie, mentre è essenziale comprendere fino in fondo le dinamiche profonde che generano il disagio. Per farlo, bisogna camminare insieme, confrontarsi e andare, appunto, in profondità. Siamo chiamati a trasformare i segni dei tempi in segni di speranza, per trovare nuove vie di giustizia riparativa e trasformativa: ecco perché non possiamo, come comunità, girarci dall’altra parte, ma dobbiamo affrontare con responsabilità e prossimità le ferite del nostro tempo».